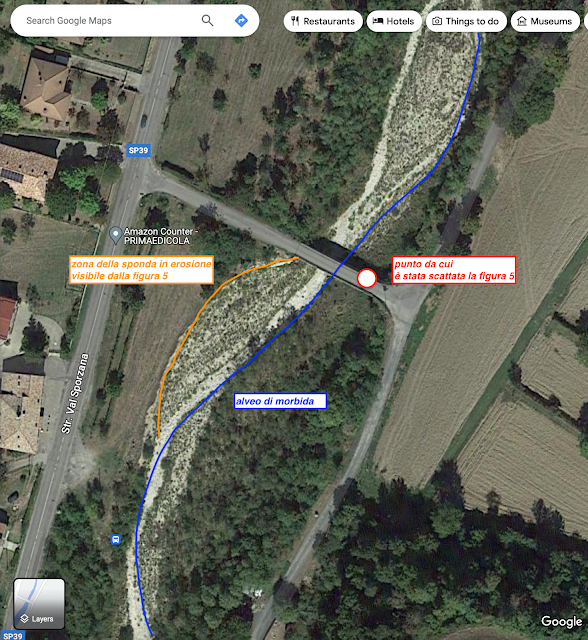Niels Bohr diceva che "è difficile fare delle previsioni, specialmente per il futuro". Quanto sta succedendo nei dintorni di Grindavik, nella penisola di Reykjanes è una applicazione pratica in senso vulcanologico di questo detto: dopo che nella seconda metà di novembre l’eruzione sembrava sempre più prossima, nella prima metà di dicembre le possibilità di un evento erano fortemente diminuite. Poi, all’improvviso, il 18 dicembre alle 22.17 il magma ha iniziato a fuoriuscire da una frattura lunga circa 4 km. L'eruzione si trova vicino a Sundhnúkagígar, circa quattro chilometri a nord-est di Grindavík. L'eruzione è stata preceduta da uno sciame sismico iniziato alle ore 21:00.
Secondo il comunicato delle ore 2.00 italiane di stanotte 19 dicembre del servizio meteorologico islandese (che svolge anche la funzione di sorveglianza sismica e vulcanica, dato che il servizio geologico nazionale si occupa soprattutto di geotermia e impatti ambientali) questa notte la sismicità e le misure GPS indicano che l'intensità dell'eruzione vulcanica, iniziata circa alle 22.00 in Italia della sera del 18 dicembre, sta diminuendo. Ma questo non indica una conclusione dell'eruzione, ma piuttosto che la fuoriuscita di magma sta raggiungendo uno stato di equilibrio. Questo sviluppo è stato osservato all'inizio di tutte le eruzioni nella penisola di Reykjanes negli ultimi anni. La fessura eruttiva è lunga circa 4 km, con l'estremità settentrionale appena ad est di Stóra-Skógfell e l'estremità meridionale appena ad est di Sundhnúk. La distanza dall'estremità meridionale fino all’estremità NE di Grindavík è di quasi 3 km.
Avevo già descritto la situazione un mese fa (il 15 novembre) quando la deformazione era estremamente intensa ed il magma era a poche centinaia di metri dalla superficie: il servizio meteo islandese forniva tutti i giorni nuovi aggiornamenti indicando nella homepage che l’eruzione fosse estremamente probabile. Poi le cose si sono relativamente calmate e l’avvertimento è scomparso dalla sua homepage.
Il 6 dicembre venne comunicato che in base alla modellazione geodetica l’afflusso di magma era probabilmente cessato. Quindi la possibilità di un'eruzione era notevolmente diminuita ma tuttavia il futuro avrebbe potuto riservare evoluzioni improvvise. E difatti nella immagine a sinistra si vede la carta pubblicata contestualmente al comunicato, valida fino al 20 dicembre della probabilità di una eruzione, dove ho indicato in rosso l’area interessata da ieri sera dall’eruzione. In ogni caso l’avvertenza era che “le condizioni all'interno e all'esterno delle zone di pericolo delimitate possono cambiare con poco preavviso” (come dovevasi dimostrare...). Da quel momento comunque era scomparsa dallla homepage del servizio meteorologico l’avviso sulla probabilità di una eruzione. Nell’immagine a destra invece si vede la zona interessata effettivamente dall’eruzione.
E arriviamo dopo una settimana di silenzio al comunicato del 13 dicembre, in cui si riportava che che il sollevamento nell'area intorno a Svartsengi stava continuando, ritenendo che il luogo più probabile per una potenziale eruzione in queste condizioni fosse più o meno quello dove poi effettivamente è avvenuta.
Il 15 dicembre nella zona interessata dall’intrusione magmatica continuava una sismicità generalmente debole, concentrata soprattutto nei pressi di Hagafell (contraddistinta da una stella rossa). Tra il 12 e il 15 sono stati registrati 460 terremoti, di cui 30 superiori a M 1.0. Il terremoto più forte in questo periodo è stato di magnitudo 2.8 vicino a Hagafell martedì mattina. Invece i dati provenienti dalle stazioni GPS e dalle immagini radar satellitari mostravano che il sollevamento intorno a Svartsengi stava comunque continuando (stella verde). Si segnalava inoltre che il magma continuava ad accumularsi e che continuava la possibilità di una eruzione o della formazione di nuove fratture che il magma avrebbe riempito.
Il 16 dicembre viene comunicato che negli ultimi giorni il tasso di deformazione era leggermente diminuito, ma anche che era troppo presto per dire che l’accumulo di magma si fosse fermato e che Il 20 (domani…) sarebbe stata emessa una nuova carta in sostituzione di quella del 6.
Ovviamente gli eventi hanno superato questa notizia.